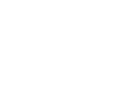

E’ da tempo che si susseguono gli allarmi sul problema della carenza idrica del territorio che fa riferimento al fiume Po, con tutte le preoccupazioni che ne derivano per il settore agricolo. La situazione sembra tuttavia essere ormai oltre il livello di guardia, come certificato nei giorni scorsi dall’Osservatorio sugli utilizzi idrici del maggiore fiume italiano, che ha parlato di una crisi senza precedenti negli ultimi settant’anni.
Sabrina Diamanti, presidente del Conaf (Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) conferma che quelli attuali sono “dati spaventosi, si parla di una riduzione delle precipitazioni nei territori del Nord e al Centro del nostro Paese che arriva al sessanta per cento. Quest’anno la situazione particolarmente critica scaturisce anche da altre circostanze, ovvero un inverno caratterizzato da forte siccità e da mancanza di precipitazioni nevose, a cui si sono aggiunti episodi temporaleschi che hanno fatto danni enormi”.
La presidente del Conaf spiega, sintetizzando quella che è la posizione della categoria professionale che rappresenta, che occorre per porre rimedio “un approccio complessivo e una programmazione ampia. Bisogna aumentare le infrastrutture che occorrono per la conservazione dell’acqua, invasi e bacini imbriferi. Erano investimenti che un tempo si facevano con una certa frequenza, ma che sembra siano stati abbandonati. Poi l’efficienza: alcune amministrazioni locali, anche grazie al nostro lavoro, hanno compreso l’importanza e le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la risistemazione della rete idrica. Parliamo di un problema che interessa gran parte del Paese: le perdite superano anche il 40 per cento. C’è inoltre il contributo che può essere offerto dalla nostra professione, dalla scelta delle tecnologie più efficienti, penso ad esempio all’agricoltura di precisione per l’irrigazione, alla modernizzazione degli impianti di distribuzione, ma anche alla scelta delle colture più adatte e resistenti e all’incremento di fertilità del suolo per accrescerne le capacità di accumulo e trattenimento dell’umidità. Infine, non bisogna dimenticare l'importanza della corretta gestione dei territori montani e submontani; boschi coltivati e curati consentono di avere versanti stabili e forniscono un importante contributo alla regimazione delle acque meteoriche e alla capacità di ritenuta del suolo”.
Per Diamanti quella che manca è “una programmazione dal livello centrale. Le buone iniziative, quando ci sono, sono spot, scaturiscono dalla sensibilità e dalla bravura degli amministratori e dei tecnici locali. Il PNRR rappresenterebbe un’occasione anche da questo punto di vista: è vero che è nato in un momento in cui le priorità erano legate al settore sanitario e ha risentito di una certa nostra abitudine a investire nelle infrastrutture cosiddette ‘grigie’, come le strade, ma confidiamo ancora nella possibilità di recuperare nella direzione degli investimenti che ho citato”.
Eligio Troisi, che oltre a essere dottore agronomo ed esperto di sviluppo locale è membro del Consiglio direttivo della sezione Campania dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, inquadra la crisi nel contesto globale segnato dal cambiamento climatico che “ci allontana da una logica di stagionalità che caratterizzava i decenni passati, ovvero l’alternanza di caratteristiche climatiche legate al regime pluviometrico. Nella mia zona, ovvero la parte meridionale della Campania, non registriamo ancora una riduzione del quantitativo complessivo di acqua che precipita nel corso dell’anno, piuttosto quello che si nota in modo insistente, maggiormente negli ultimi dieci anni, è la variazione della distribuzione. Sempre più spesso lunghi periodi di siccità si alternano a piogge copiose, concentrate in poco tempo”.
E’ inevitabile, dice Troisi, che “la pratica agricola ne risente e non c’è sempre la possibilità di tamponare con le irrigazioni. Ciò che occorre potenziare sono le politiche, e le infrastrutture, per il riutilizzo delle acque meteoriche: quando infatti le precipitazioni sono concentrate in periodi di tempo limitati la dispersione non può che essere maggiore e bisognerebbe predisporre gli strumenti per ridurla e avere la possibilità di riutilizzare successivamente la risorsa idrica. Vale in generale, anche per le aree urbane, dove ogni piccolo intervento dovrebbe quando possibile prevedere la realizzazione di questi principi e queste infrastrutture, ma è nel campo agricolo che la necessità è evidente: servirebbe realizzare una rete capillare di piccoli bacini artificiali di accumulo delle acque meteoriche, in modo da avere la disponibilità per interventi di soccorso nei periodi di siccità. C’è da tenere conto che settanta, ottanta giorni senza acqua mettono a rischio la vita delle piante, oltre che le produzioni, anche per quelle colture che ne hanno, in generale, meno bisogno perché più resistenti alla siccità".
Andrea Scarchilli – Ufficio stampa Istituto Nazionale di Urbanistica