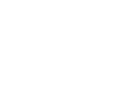

Nell’area dei Campi Flegrei l’allarme dovuto ai recenti fenomeni sismici, anche di una certa rilevanza, è tornato da tempo a essere una consuetudine. Si tratta di un territorio particolarmente esteso e popolato: tra i comuni coinvolti ci sono Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, ampie porzioni di Napoli. Mezzo milione di abitanti, 800mila se si considerano gli effetti della ricaduta delle ceneri, in caso di eruzione. Eppure, dichiara il professor Roberto Gerundo, proboviro componente del Consiglio direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, la questione viene affrontata esclusivamente “attraverso provvedimenti, sicuramente utili, che tamponano l’emergenza mirando alla messa in sicurezza degli edifici pubblici o il sostegno per la riparazione di quelli che hanno subito danni gravi. Non sembra che si voglia affrontare in modo strutturale il problema di fondo”.
Gerundo la illustra: “Il bradisismo è un fenomeno immanente. Se la sismicità dovuta all’innalzamento del suolo, che dura con alti e bassi, in epoca contemporanea, sin dagli anni ’50, dovesse continuare anche per i prossimi venti, trent’anni, come si affronterebbe la sfida della sopravvivenza di questo territorio, che provvedimenti prendiamo per fare sì che non si svuoti lentamente, ma inesorabilmente, di attività economiche e di popolazione, come, in modo strisciante, sta già avvenendo? Come programmare il suo futuro e fare sì che vi si continui a investire, a sostenere l’economia locale e il valore del patrimonio immobiliare? Se non riusciamo a dare uno slancio di crescita socio - economica al territorio, esso andrà progressivamente a depotenziarsi dei suoi caratteri e sarà progressivamente abbandonato, con un danno significativo per tutta l’economia nazionale. Il nodo è come attivare investimenti, imbastire un’azione che tenti di frenare o, addirittura, ribaltare una prospettiva di declino”.
Tanto più se si considera che l’area flegrea è già vittima, in buona parte, di una precedente tendenza allo spopolamento che la accomuna alle aree interne del nostro Paese. Il rappresentante dell’INU invoca “un dibattito, per cominciare a focalizzarsi su tale tema. È necessario che sia delineato un programma di crescita, quale sintesi di progresso e sviluppo”.
Gerundo solleva interrogativi scomodi, per la politica, ma necessari, specialmente tenuto conto che il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei non accenna a diminuire e, precisa che “è tutt’altro che improbabile immaginare una sua persistenza nei prossimi decenni. Il bradisismo presidia questo territorio da millenni e, in epoca moderna, da un’eruzione che si è verificata nel 1538 e a cui ha fatto seguito una lunga fase di subsidenza del suolo. In quell’epoca, dopo l’eruzione, i governanti fecero una politica di reinsediamento attraverso l’assegnazione, a nuovi coloni, delle cosiddette terre emerse”. Dal secolo scorso, a intervalli (anni Cinquanta per 50 cm, anni Settanta per 177 cm, anni Ottanta per 179 cm, ora per 144 cm, a meno di una subsidenza, fra il 1985 e il 2005, di 94 cm), il suolo ha iniziato a risalire generando una diffusa e più intensa sismicità che, dal 2023, ha cominciato ad essere più frequente, crescendo di magnitudo. Ora si procede al ritmo di un centimetro e mezzo al mese, in media, di sollevamento del suolo. Niente a che vedere con la risalita di 8 metri che precedette l’eruzione del 1538, siamo all’incirca alla metà, a cominciare dal 1950. “Ammesso che il fenomeno non si arresti, assumendo una prospettiva mediana, ci potrebbero volere altri 75 anni prima di un evento parossistico, un tempo che consentirebbe l’ammortamento finanziario di gran parte degli investimenti da effettuarsi”.
Conclude Gerundo: “Nei prossimi decenni, si dovrà convivere con il bradisismo, creando, nel breve - medio periodo, nuove economie urbane e territoriali compatibili, non affidandosi esclusivamente al purtroppo magro sostegno della finanza pubblica”.
Andrea Scarchilli - Ufficio stampa Istituto Nazionale di Urbanistica