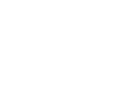

L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia in un convegno tenuto il 14 luglio scorso alla Casa dell’Architettura ha presentato una proposta di revisione del DPR 328/01 elaborata dalla Commissione Competenze dello stesso Ordine, con l’obiettivo di unificare tutte le figure professionali nella denominazione di “Architetto”. Giuseppe De Luca, membro effettivo e già segretario generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, ci espone le ragioni per cui, ritiene, bisogna opporsi a questo approccio.
De Luca è ordinario di Urbanistica all’Università degli studi di Firenze, già direttore del Dipartimento di Architettura della stessa università, nonché Componente esperto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a Roma. Secondo lui “questa proposta cancella la pluralità delle competenze e delle culture progettuali che oggi abitano le trasformazioni del territorio. Architetti, Urbanisti, Paesaggisti, e in pochissima parte, perché non ci sono percorsi formativi ad hoc, Conservatori non sono intercambiabili. L’idea di riportarli a un’unica figura generalista, 'l’Architetto', è un ritorno al Novecento, quando il sapere tecnico era ancora considerato unico e indiviso. Invece, la complessità del presente richiede saperi distinti, cooperanti ma non confusi. Urbanisti e pianificatori, in particolare, hanno un compito diverso, che non può essere fagocitato da una visione architettocentrica. La proposta non è comunque nuova, ogni tanto emerge, l’ultima volta è stato per mano dell’allora Presidente nazionale Giuseppe Capocchin”.
Coloro che la promuovono dicono la che la proposta sostiene l’interdisciplinarità, la necessità di visione olistica, la trasversalità delle competenze, ma secondo De Luca “la trasversalità non richiede l’unificazione burocratica delle figure professionali. Al contrario, richiede la piena consapevolezza delle differenze tra saperi. Il pianificatore lavora in uno spazio pubblico e con finalità pubbliche, spesso in funzione di supplenza rispetto a carenze amministrative o decisionali. È un mestiere che richiede indipendenza, responsabilità etica, visione strategica e capacità di trattare beni comuni, spazi collettivi e regole d’uso del territorio, che necessita di una forma mentis diversa e specifica. Il progetto urbanistico non è un edificio più grande”. Tanto più che la figura dell’Urbanista e quella dell’Architetto si differenziano in modo sostanziale, a partire dal “luogo dell’azione e dal tipo di committenza. L’architetto lavora prevalentemente su incarico privato, su oggetti costruiti, con un contratto bilaterale. Lavora quindi soprattutto nel dominio privato. L’urbanista agisce su incarico pubblico, in nome e per conto della collettività. Lavora quindi esclusivamente nel dominio pubblico. Il suo lavoro è regolato da un disciplinare, non da un contratto. Inoltre, l’urbanista non produce 'oggetti', ma elabora regole, quadri strategici, indirizzi politici, scenari e visioni di riferimento che diventano la trama entro cui prende corpo la società. Difatti, nel nostro ordinamento, è una figura 'costituzionale': l’art. 117 della nostra Carta tutela la materia urbanistica come ambito di responsabilità pubblica”. E all’Ordine degli Architetti di Roma che afferma che la frammentazione delle professioni indebolisce la rappresentanza e crea confusione. Il rappresentante dell’INU replica che è “vero solo se si guarda alla rappresentanza da un’ottica corporativa e non da quella culturale e democratica. La diversità dei profili è una ricchezza da difendere, non un problema da normalizzare. Il vero rischio è proprio quello che l’urbanista venga ‘sostituito’ da un architetto che non ha né la formazione, né la cultura, né la visione necessarie per affrontare i temi del governo del territorio. È già accaduto in passato, e le conseguenze – basti pensare ad alcune derive della cosiddetta rigenerazione urbana – sono sotto gli occhi di tutti. Il caso Milano è emblematico. L’aver cancellato la distinzione tra demolizione/ricostruzione e inglobato tutto nella ristrutturazione edilizia ha permesso di eludere gli strumenti di pianificazione attuativa, non solo, ma ha generato l’idea che il territorio urbanizzato sia uniforme, per la presenza delle urbanizzazioni primarie, e indistinto, tale che può sopportare e accettare tutto. È un esempio lampante di come l’indebolimento del pensiero urbanistico abbia aperto la strada alla deregulation. È questo che ci attende con l’unificazione? Una pianificazione senza regole, subordinata all’edilizia? L’urbanista non è un mediatore tecnico, ma un costruttore di orizzonti condivisi. E’ chiaro che per un pianificatore urbanista l’interesse pubblico è il faro della sua azione anche quando riceve un incarico, egli non può allinearsi all’interesse del solo Municipio, della sola Provincia Metropolitana, o della sola Regione, che sono entità giuridiche e giuridicamente rilevanti, per le quali lavora e/o riceve l’incarico. Per questa figura è eticamente normale che la sua azione deve essere avvicina a quella della Comunità insediata, intesa come entità sociale, economica e culturale che esprime beni comuni e spazi collettivi. L’esito di questo accordo deve essere fissato in un piano che abbia un forte contenuto strategico e l’indicazione di priorità nell’azione. Solo così si può passare da un interesse pubblico gerarchico, certificato d’imperio nelle Assemblee elettive, ad un interesse comune riconosciuto nelle Assemblee elettive, ma con-diviso esplicitamente e in forma cooperativa nella comunità tra gli attori sociali presenti”.
Attenzione anche agli “elenchi disciplinari aperti” proposti dall’OAR per dare visibilità alle competenze perché “quegli elenchi non hanno valore ordinistico, non corrispondono a titoli professionali e non garantiscono alcun riconoscimento pubblico. Sono espedienti per accorpare sotto un’unica etichetta professionale un mondo che è fatto, invece, di storie e missioni diverse. Sarebbe più onesto e utile – anche in chiave europea – ragionare su come rafforzare le specificità, non su come assorbirle. Quello che serve è difendere e rilanciare il profilo autonomo del pianificatore. Rafforzarne il riconoscimento ordinistico, prevedere Albi distinti, come già avviene in altri Paesi, e rendere visibile la sua insostituibile funzione pubblica. Oggi, di fronte alla crisi climatica, alla sfida della rigenerazione ecologica, alla necessità di governare processi complessi, il pianificatore è più che mai necessario. Anziché uniformarlo, dovremmo valorizzarlo, tanto più che i percorsi di formazione sono già distinti. Se lo faccia dire da me che ho diretto il Dipartimento di Architettura a Firenze, dove sono presenti tutti i corsi di laurea oggi possibili in Italia: Architettura, Architettura del paesaggio, Pianificazione urbanistica, Design e Moda. Tornando a noi, i pianificatori urbanisti hanno percorsi universitari specifici, che nascono già negli anni ’70, a partire dal corso fondativo dello IUAV di Venezia nel 1970. Da allora si sono consolidati numerosi percorsi triennali e magistrali autonomi – oggi ne sono più di 20 solo in urbanistica e pianificazione – che prevedono un impianto disciplinare fortemente caratterizzato: più della metà degli insegnamenti è riconducibile all’urbanistica, alla tecnica urbanistica, all’economia urbana, alla gestione informatica del territorio, alle scienze e valutazione ambientale, alla tutela del patrimonio, fino alla progettazione infrastrutturale e paesaggistica. Non si tratta di una formazione 'edilizia', ma di una formazione strategica, capace di leggere e governare i sistemi territoriali e urbani nella loro complessità”.