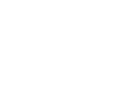

Il successo del tredicesimo Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume, che si è svolto all’Aquila il 20 e il 21 novembre scorsi, fa ben sperare sulla crescita complessiva di uno strumento che ha il pregio di coniugare il perseguimento di obiettivi ambientali e di sviluppo con la partecipazione delle comunità locali. L’evento dell’Aquila ha fatto registrare 350 presenze e un dibattito molto ricco, che ha visto alternarsi 70 relatori ai talk e alle tavole rotonde. L’Istituto Nazionale di Urbanistica ha patrocinato l’evento e contribuito alla sua organizzazione.
Circa 40 poster provenienti da tutta Italia hanno fornito uno spaccato dello stato dell’arte dei CdF. “Fotografia” ma anche sguardo al futuro: all’evento sono state infatti illustrate da alcuni dei parlamentari che le hanno presentate le sei risoluzioni in discussione alla Camera e al Senato che hanno l’obiettivo di rafforzare l’incisività e l’efficacia dei Contratti.
Il punto è infatti come sostenerne la diffusione e l’attuazione in maniera sistemica, a partire dai risultati raggiunti negli ultimi anni, come ha sottolineato il coordinatore nazionale del TNCdF Massimo Bastiani nella sua relazione: “Poter contare su circa 300 processi attivati e distribuiti in tutte le regioni italiane e su 104 contratti sottoscritti è senz’altro un buon punto di partenza, ancor più se consideriamo che per ogni contratto sono mediamente coinvolti tra i 10 e i 20 comuni, oltre a innumerevoli soggetti privati, imprese e associazioni. I Programmi d’Azione dei CdF prevedono interventi di media compresi tra i 10 e 80 milioni di euro dimostrando come il raggiungimento degli obiettivi ambientali sia in grado di incidere positivamente anche sull'occupazione e la creazione di posti di lavoro. L’azione ambientale è economicamente rilevante se consideriamo che ogni euro investito in progetti ambientali e di ripristino della natura può generare da 4 a 38 euro di valore economico. La complessità, il numero e la variabilità dei fenomeni climatici, che interessano un territorio fragile come il nostro, richiedono approcci sistemici e multidisciplinari. Dobbiamo cioè guardare oltre le pratiche convenzionali, oltre i processi decisionali chiusi e gli approcci settoriali, nuove sfide richiedono nuovi strumenti”. Bastiani ha ricordato che “l’innovatività dei Contratti di Fiume sta nel consentire di intervenire sui diversi livelli di complessità e in scenari multirischio, predisponendo strategie di lungo e breve termine, agendo attraverso processi decisionali inclusivi site-specific e risk-specific. Nei Programmi d’Azione dei CdF, accanto ai progetti strutturali, troviamo anche molte azioni non strutturali che incidono sulla consapevolezza e la formazione delle comunità. La maggioranza delle persone non ha ancora oggi la percezione esatta di quello che i cambiamenti climatici stanno producendo e potrebbero produrre già in un prossimo futuro, e i CdF possono contribuire a comunità più consapevoli, responsabili e quindi collaboranti. Il Contratto di Fiume (il cui raggio d’azione si estende ai laghi, aree umide, coste, ecc…) è ascrivibile tra gli strumenti di programmazione strategica negoziata, poiché consente attraverso la sua valenza pattizia e territoriale di raggiungere un’integrazione contemporaneamente ‘orizzontale e verticale’ tra interessi, comunità, programmi e piani”.
Nel corso del Tavolo dell’Aquila sono stati anche assegnati due premi: all'attore drammaturgo Marco Paolini e a Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi.
Andrea Scarchilli - Ufficio stampa Istituto Nazionale di Urbanistica