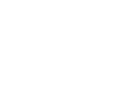

L’edizione 2025 del Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, a cura dell’ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), conferma che nel nostro Paese, il consumo di suolo continua a crescere: nell’ultimo anno sono stati trasformati in aree artificiali 83,7 chilometri quadrati di territorio, con un incremento dal 2023 del 15,6 per cento. Di contro, si osserva positivamente un modesto processo di ripristino delle aree naturali, pari a circa 5 chilometri quadrati, che porta a un saldo netto di consumo pari a 78,5 chilometri quadrati. Le regioni con una più alta copertura artificiale del suolo sono la Lombardia, il Veneto e la Campania, mentre il tasso più alto di consumo di suolo si registra nel 2024 in Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia e Lazio, senza alcuna correlazione diretta tra tendenze demografiche e suolo consumato.
Andrea Arcidiacono, responsabile della Community dell’Istituto Nazionale di Urbanistica “Consumo di suolo e servizi ecosistemici”, sottolinea come il Rapporto ISPRA confermi una preoccupante crescita delle dinamiche di consumo di suolo, secondo un trend che “prosegue persino con un’intensità leggermente maggiore rispetto all’ultimo anno. Malgrado emerga in questi ultimi anni sia più condivisa l’attenzione politica e disciplinare alla limitazione del consumo di suolo, nella realtà delle pratiche questo continua a essere rilevante. Da segnalare come dal Rapporto emerga un impatto crescente della logistica e, in parte, dei data center, sul consumo di suolo, in particolare nelle regioni in cui queste attività svolgono un ruolo economico sempre più rilevante, come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Piemonte. Altrettanto significativo è il dato sulle energie rinnovabili che mostra una incidenza di circa il 15% del totale dovuta alla localizzazione di pannelli fotovoltaici a terra: infrastrutture fondamentali per la transizione ecologica che producono spesso un impatto elevato sul suolo, risorsa naturale i cui servizi ecosistemici svolgono un ruolo decisivo per il conseguimento della neutralità climatica. Un’importante novità del Rapporto è l’introduzione del dato relativo al riuso, che fornisce un’informazione quantitativa sulle azioni di rigenerazione del suolo; interventi di naturalizzazione che restituiscono parte di quelle proprietà biofisiche perse dai suoli impermeabilizzati. In termini quantitativi il dato è ancora contenuto ma, pur nella difficoltà di una misurazione puntuale e completa di questo fenomeno, evidenzia l’affermarsi di una tendenza importante nelle strategie di rigenerazione urbana. I costi rilevanti di queste azioni di ripristino rendono sempre più necessario continuare rafforzare le politiche di riduzione e azzeramento del consumo di suolo, per preservarne quelle funzionalità ecosistemiche che sono fondamentali per la qualità della nostra vita”.
Arcidiacono sottolinea che “per quanto la necessità di ridurre il consumo di suolo e l’accresciuta sensibilità politica e disciplinare sull’importanza di questa risorsa per il nostro benessere, abbia portato in diverse Regioni all’approvazione di dispositivi legislativi specifici, la conferma dell’intensità del fenomeno evidenzia la parziale efficacia e l’elevata eterogeneità dei quadri normativi regionali che di fatto consentono il perdurare di previsioni urbanizzative che rendono ancora molto lontano l’obiettivo dell’azzeramento del consumo netto di suolo al 2050 indicato dall’Unione Europea. La mancanza di una legge nazionale di principi per il governo del territorio costituisce un limite sostanziale all’attuazione di politiche efficaci e coerenti per la limitazione del consumo di territorio. Non basta una legge settoriale ma è necessaria una legge organica di riforma della legge urbanistica nazionale del 1942, che individui tra i principi del governo del territorio la limitazione del consumo di suolo e le conservazione e valorizzazione delle risorse naturali. Un percorso di riforma a cui l’INU ha contribuito direttamente con una proposta di un articolato di legge presentato in Parlamento nel luglio dello scorso anno”.
Il quadro nazionale si confronta e interagisce con quello dell’Unione europea, che ha riservato proprio nei giorni scorsi importanti novità. Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo (Soil Monitoring Law), da recepirsi da parte dei paesi membri entro tre anni, per l’istituzione di un sistema comune di monitoraggio e valutazione dello stato dei suoli. La nuova direttiva si aggiunge sinergicamente all’approvazione del regolamento per il ripristino della natura, la cosiddetta Nature Restoration Law. Si tratta evidentemente di strumenti che avranno bisogno di tempo per andare a regime. L’esponente dell’INU sottolinea che “la direttiva sul monitoraggio del suolo pur essendo indubbiamente un risultato positivo, rimane un provvedimento, come rilevato da molti, per certi versi timido. Non introduce, infatti, prescrizioni per la limitazione del consumo di suolo, ma piuttosto metodologie e parametri comuni per il monitoraggio delle condizioni biofisiche e chimiche dei suoli che permetteranno di avere informazioni comparabili sulla salute del suolo tra tutti i Paesi europei. Sappiamo che più del 60 per cento dei suoli europei non sono in salute e bisogna lavorare per migliorare questo dato, ma la direttiva in questione di fatto fornisce solo uno strumento, pur importante, di misurazione comune. Per usare una metafora, ci fornisce un termometro ma non stabilisce la cura. È importante segnalare di contro che la Nature Restoration Law indica alcuni obiettivi importanti per ripristinare gli ecosistemi terrestri in modo ampio, incrementando naturalità e aree verdi: questo non potrà che avere un effetto significativo sul governo del territorio, a patto che queste indicazioni siano sostenute da una legge nazionale di principi sul governo del territorio”.
Andrea Scarchilli - Ufficio stampa Istituto Nazionale di Urbanistica