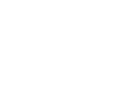
di Rosario Pavia, responsabile della Community dell'Istituto Nazionale di Urbanistica "Porti città territori"
Le nuove Linee Guida per la redazione dei piani portuali, in via di approvazione dal Consiglio Superiore dei LL.PP., non modificheranno l’attuale quadro normativo e non contribuiranno a superare la consolidata farraginosità del processo di pianificazione portuale.
Il DPSS (introdotto dal DL169/2016) avrebbe dovuto delineare la strategia per lo sviluppo dei porti di competenza delle Autorità di Sistema Portuale (ADSP) in una visione integrata di area vasta territoriale. È difficile non riconoscere che nell’attuale contesto normativo il ruolo del DPSS risulti fortemente depotenziato. La mancanza di una verifica sul piano ambientale (VAS), lo scarso coinvolgimento degli enti locali fanno del DPSS un semplice documento d’indirizzo, un programma di intenzioni, un memorandum per azioni future, tutto interno alle azioni delle Autorità Portuali. Anche la scelta di centralizzare le politiche di sviluppo dei porti (il DPSS è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Coordinamento nazionale delle ADPS) ha indubbiamente prodotto una condizione di distacco e di conflitto del rapporto tra Comuni Regioni e Autorità Portuali (vedi Sentenza Corte costituzionale n. 6/2023).
Senza il passo successivo, senza il PRP del singolo porto, il DPSS perde di incisività: per l’attuazione delle opere e il cambio delle destinazioni funzionali prevale, infatti, il PRP vigente (la cui approvazione può risalire a molti anni indietro). È questa la ragione che ha portato, negli anni recenti, a moltiplicare le richieste di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF). Invece di promuovere il difficile e lungo processo per la definizione di un nuovo PRP le Autorità Portuali preferiscono ricorrere al Consiglio Superiore dei LL:PP. per l’approvazione di un ATF (che si conferma sempre di più come l’espediente procedurale per semplificare l’attuazione di opere di completamento, riorganizzazione, modifica di porzioni, spesso consistenti, di ambiti portuali definiti dal PRP vigente). È quest’ultimo in definitiva a rimanere il dato certo di riferimento. L’ATF deve essere infatti coerente con il piano in vigore e le sue norme di attuazione. Certo la richiesta di ATF, in presenza di un DPSS approvato, dovrà essere compatibile con gli indirizzi di quest’ultimo, ma sul piano formale è il PRP vigente ad essere il vero vincolo cui, anche in sede di Consiglio Superiore LL.PP. si fa riferimento.
La debolezza del DPSS è ormai un dato di fatto: se ne esce solo con una riforma complessiva del sistema di pianificazione portuale, in grado di dare autorevolezza alla fase strategica (che inevitabilmente dovrà essere sottoposta a VAS e condivisa sia a livello centrale - ma ricordiamolo il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica del 2015 non ha avuto seguito -, sia a livello locale, coinvolgendo Comuni, Regioni operatori) ed efficacia alla fase operativa, dando ai piani portuali un carattere di piani di settore e di programmi di opere da sottoporre a VIA (si veda in proposito sulla Newsletter INU del 23-11-2024 il mio intervento Le nuove Linee Guida per la pianificazione portuale).
In attesa che si avvii questo processo normativo della pianificazione portuale e nel contempo si capisca in quale direzione si svilupperà la riforma della governance del sistema portuale nazionale (da alcuni mesi si parla di un organismo nazionale di coordinamento, di riduzione del numero delle ADSP, di apertura ai privati nella gestione dei porti), può essere utile proporre una procedura metodologica per la redazione dei PRP coerente con la normativa attuale, con l’obiettivo di semplificarne il processo e la strumentazione.
Assumendo come riferimento quanto si sta elaborando nella pianificazione urbanistica (INU) e in particolare a seguito di alcune leggi urbanistiche regionali (ad es. Legge urbanistica dell’Emilia-Romagna n.24/2014), il PRP potrebbe articolarsi in tre componenti funzionali: strutturale-strategica, regolativa, operativa.
La componente strutturale-strategica è quella definita per ogni porto del sistema dal DPSS, attraverso cui sono individuate le aree portuali operative di competenza dell’ADSP e quelle di interazione porto-città, di competenza dell’ente locale. L’ambito operativo del porto (su cui si applica il PRP) potrebbe essere distinto in un sotto ambito relativo al porto esistente nella sua conformazione consolidata in cui saranno previsti interventi diretti e interventi di ATF e in un sotto ambito in cui sono previsti programmi significativi di trasformazione e di ampliamento delle aree e delle infrastrutture portuali. Il sotto ambito del porto consolidato è disciplinato da una specifica regolamentazione (componente regolativa): norme attuative per gli interventi diretti e procedure semplificate per gli ATF (è proponibile che si faccia riferimento a una tipizzazione degli ATF su cui il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso parere favorevole). Mentre la gestione ordinaria e l’adeguamento funzionale del porto si realizza nel sotto ambito consolidato, lo sviluppo del nodo portuale si realizza nel sotto ambito operativo in cui si sono localizzati i programmi complessi di trasformazione e ampliamento. Questi ultimi possono essere definiti con elaborati tecnici essenziali di indirizzo progettuale e prestazionale (idonei alle verifiche di VAS). La loro definizione sarà proposta successivamente in dettaglio, in relazione alle dinamiche e alle esigenze del trasporto marittimo e del contesto funzionale e ambientale del porto. Come programmi di opere saranno soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).
L’articolazione del porto operativo in due sotto ambiti consente di semplificare l’iter di formazione del PRP: da un lato si dà rilievo al porto consolidato, dall’altro si alleggerisce la definizione dei programmi di maggiore impegno, la cui realizzazione dipende da una pluralità di fattori e di variabili.